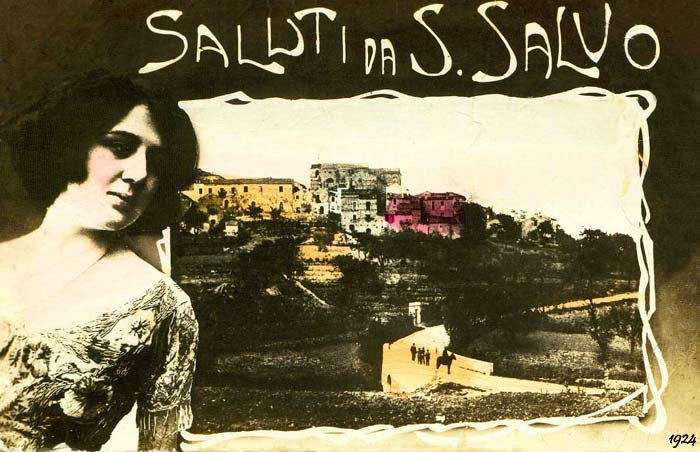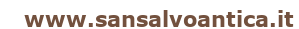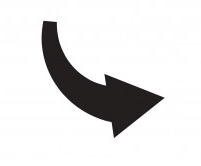Franco Lestingi
Chi invece, arrivò con i pantaloni militari senza strappi
e ben stirati, fu
Franche lu ’nfurmìre (Franco
l’infermiere), all’anagrafe Francesco Lestingi (1931 -
1980), da Trani, che come si deduce dall’appellativo
stesso con il quale lo chiamarono i sansalvesi, di
professione faceva l’infermiere.
La storia di Franco, nella nostra cittadina, inizia
intorno agli anni ’52-’53 quando, militare di leva, scese
alla vecchia stazione ferroviaria per far visita, durante
una licenza, ad alcuni suoi amici tranesi, ex vicini di
casa, sposati a San Salvo, tra i quali Donato Talamo e
Carlo Manfra, chiamato quest’ultimo
Carlùccie lu
tranàse.
Qui conobbe Assunta (1927 - 2001), una ragazza del luogo
che era nata a Mafalda, ma che mafaldese, o meglio
ripaltese non era (Mafalda un tempo si chiamava Ripalta),
essendo nata lì per caso, sulla sponda sud del fiume
Trigno. Era successo che sua mamma Cristina Budano,
originaria di Villalfonsina, la partorì senza assistenza
alcuna, mentre era al seguito del marito Vincenzo,
originario di Manoppello (PE), cavapietre, che lavorava a
San Salvo a lu Cavìute de la ràne (alla cava della
sabbia), che quel giorno stava lavorando ai bordi del
fiume in territorio mafaldese. La misero a nu puanìre (in
un paniere) e risalirono a Mafalda, dove la registrarono.
Il nostro Franco, vestito da militare, appena la vide se
ne invaghì perdutamente, e le promise eterno amore.
Fu di parola, non per niente si chiamava Franco. Dopo il
congedo, fece un biglietto del treno di sola andata,
destinazione San Salvo, e sceso alla vecchia stazione
ferroviaria, salì sull’altare della Chiesa parrocchiale di
San Giuseppe, coronando per sempre il suo sogno d’amore
con l’amata Assunta. Era il 18 Ottobre 1956.
Franco, il 3° da sinistra,
infermiere durante il servizio militare di leva
La storia di Franche lu nfurmìre o lu ’mburmìre, così lo
chiamavano i sansalvesi, si svolge e si intreccia in due
periodi storici ben distinti della nostra cittadina:
quello ante SIV, in cui il paese era immerso tra le
campagne, e quello immediatamente successivo, in cui
diventa un importante polo industriale del mezzogiorno.
Volendo adoperare un parallelismo, è come se Franco e San
Salvo, siano cresciuti un po’ insieme.
All’epoca del suo arrivo c’erano solo quattro medici: Don
Vitaliano Ciocco, che era medico condotto, Don Gustavo
Cirese, Don Michele (Angelo) Di Stefano e don Peppino de
Vito, che era il più giovane.
Le visite mediche si pagavano. Erano gratuite solo per gli
iscritti all’elenco dei poveri, alla cui assistenza
sanitaria, già dai tempi del fascio, era demandato il
medico condotto, che era pagato dal Comune, e dal 1954 per
gli iscritti alla Cassa Mutua per mezzadri e coltivatori
diretti, i quali avevano iniziato per legge
obbligatoriamente a pagare i primi contributi assicurativi
e quindi godevano di una primitiva forma di assistenza
sanitaria. Poi vi era l’ONMI (Opera Nazionale Maternità
Infanzia), altro ente istituito dal fascismo, che prestava
gratuitamente la propria assistenza alle donne incinte sia
durante la gravidanza che nei primi otto mesi del
puerperio, fornendo loro alimenti e validi consigli , che
contribuirono di molto a ridurre le murticélle (la
mortalità infantile).
Per il resto la gran parte della gente, per curarsi,
doveva quindi necessariamente sborsare somme di denaro,
che piccole o grandi che erano, mettevano spesso in seria
difficoltà economica le famiglie degli ammalati, che a
volte, come nel caso dei costosi ricoveri ospedalieri,
erano costrette a firmare per necessità anche qualche
cambiale.
Befana OMNI 1961 - Si
riconoscono da sin. il dott. Giuseppe de Vito, il
maestro elementare Ugo Marzocchetti, il dott.
Vitaliano Ciocco, il Cav. Virgilio Cilli ed un
funzionario dell’OMNI. Presidente dell’OMNI a San
Salvo era la signora Maria Fabrizio, figlia di Donna
Vetalene de Cristofaro, moglie del maestro elementare
Aldo Germani.
I medici sapevano tutto questo e quindi cercavano di
essere il meno indolore possibile sia nelle richieste di
onorari, che sovente erano saldati
a zi da’ (pagherò)
ed anche nella scelta delle terapie da adottare, che erano
spesso subordinate alle condizioni economiche delle
famiglie, cercando di far acquistare loro farmaci meno
costosi.
Il vero spauracchio era però l’Ospedale. Stava a Vasto.
Molta gente non vi andava neppure
se stave a muritàure,
cioè se era moribonda. Per molti era addirittura
meje
a mure' (meglio morire), invece di affrontare le
costose degenze ospedaliere. Per questo motivo molti
anziani
stennavene li pite (morivano) nel letto
di casa
’nghe ’na fréme e ’na cacarélle (con una
leggera febbre e diarrea), con la sola assistenza dei
medici del luogo, che le provavano di tutte per cercare di
strapparli alla morte.
Andava all’ospedale solo chi si rompeva
lu vraccie o lu
péte (il braccio o il piede) e
z'aveva fa' la
ngessàtìure (immobilizzazione dell’arto con il
gesso), oppure in casi di interventi chirurgici come
l’appendicite, di cui si temeva molto la complicazione a
peritonite, o per le operazioni ai bambini
de le
donzélle (alle tonsille), chiamate anche
le
strangajüne, o alle adenoidi, in cui era necessario
l’intervento del chirurgo
’nghe l’addubbie (con
anestesia).
1952 - Il dottor Luigi
Cipolla, al centro con il camice, primario
dell’Ospedale Civile di Vasto, con alcuni
collaboratori.
Purtroppo a quei tempi non esistevano sofisticate
attrezzature diagnostiche, che erano ancora tutte da
inventare. Anche lo stesso ospedale Civile di Vasto non è
che fosse fornito di molte apparecchiature di indagine
sanitaria. Vi era
la machene pe passa’ le ragge
(macchina per gli esami a raggi X), che era
’nu
scaricarelle (trappola o piccolo congegno) che
forniva delle primordiali lastre, a volte decifrabili solo
da luminari della scienza dotati di buona vista o
marchingegni per eseguire gli esami del sangue, analisi
semplici, che servivano per lo più alla sola conta dei
globuli bianchi e rossi, ma per il resto, fatta eccezione
per poche altre attrezzature, gli ambulatori ospedalieri
non differivano molto da quelli dei medici di paese.
Per questo motivo i nostri quattro medici, erano
sopratutto dei bravi internisti, costretti per necessità e
virtù
a azzecca' (ad indovinare) le diagnosi,
svolgendo visite mediche accurate, così come avevano
imparato nelle università. Si facevano dire dal malato
addo'
j dulàve (dove avevano male),
j’attendavene lu
puàzze (contavano i battiti cardiaci dal polso),
gli tastavano
la panze (il ventre), j
tuzzuluávene
arréte la schéne (gli davano dei colpi secchi
dietro alla schiena) , gli facevano dire 33 auscultando
con il fonendoscopio le spalle, e dopo essersi fatta
un’idea di quale malattia affliggese il paziente, si
pronunciavano sulla diagnosi, sperando che non entrassero
in scena il prete ed il sagrestano, che avrebbero portato
lu morte
a suttérre (il morto sottoterra).
Peggio era andata durante il fascismo, quando in paese, vi
era rimasto un solo medico.
Era successo che
Don Cassiedore (Cassiodoro)
Artese, anziano medico antifascista,
ave' ’rziliti li
firre (aveva riposto i ferri) di medico chirurgo,
lasciando il paese tutto nelle mani del dottor Vitaliano
Ciocco, potente gerarca fascista. Non volendo avere nulla
a che fare con Ciocco, alcuni antifascisti, si recarono a
Parma, dove esercitava la professione di medico
ospedaliero Don Camillo Artese, figlio di Don Cassiodoro,
e lo convinsero a tornare.
Non lo avessero mai fatto. Si accese un fuoco peggio
de
lu foche de Sant’Antonio (herpes zoster). Tra i due
medici, restando nel campo ematologico, non corse buon
sangue e vi furono scintille che si propagarono nelle aule
istituzionali del Fascio, con il povero Don Camillo,
com’era prevedibile, ad avere, almeno inizialmente, la
peggio.
Don Camillo Artese con un
carabiniere della stazione di Cupello da cui da San
Salvo all’epoca dipendeva. La prima stazione dei
Carabinieri a San Salvo fu istituita nel 1949 con sede
in C.so Garibaldi.
Erano stati davvero tempi dolorosi e neri, quelli, per i
sansalvesi, e non solo per via del Fascio.
Prima, negli anni ‘30 vi era stata la malaria, causata
dalla risaia, che aveva mietuto alcune vittime e portato
alla protesta contro il farmacista e podestà
Do’
Ureste Artese, cognato di Ciocco, reo secondo
l’opinione pubblica, di fare affari con la vendita del
chinino per curarla. Molta gente finì in prigione. Poi fu
la volta della
trabbocolosi, così chiamavano i
sansalvesi la tubercolosi o tisi, malattia infettiva
dovuta alla cattiva e scarsa alimentazione e non mancavano
anche casi frequenti di meningite ed encefalite. "
Magne
ca’ si na’ ti ni vi téseche" (mangia, altrimenti te
ne vai tisico), era diventato un modo di dire sansalvese.
Ogni tanto si presentava qualche malattia infettiva e
contagiosa e non si faceva in tempo a curarne l'ultima che
subito diventava la penultima.
Non bastavano le malattie infettive e le frequenti
influenze virali, vi si aggiungevano anche altre dovute
sopratutto alla scarsa condizione igienica.
Una delle più temute era sicuramente
lu scàule (la
sifilide), malattia venerea incurabile, sempre in agguato
quando qualcuno frequentava le meretrici, così come
le
piáttele (le piattole, pidocchi del pube). Vi era
poi
la ràgne (la scabbia), che veniva trasmessa da
hatte e chéne arrugnunìti (gatti e cani malati di
rogna), ed altri
vrìscele (foruncoli) come “
lu
fazze lupéne” (falso lupino), così chiamato perchè
si manifestava sulla faccia o sul collo ed assumeva una
forma simile ad un lupino. Il rimedio era l'asportazione
chirurgica che lasciava antiestetiche
sanéccie
(cicatrici) sulla parte colpita e per questo era molto
temuto, sopratutto dai giovani, che dopo l'intervento
restavano
smirchilijte (con un marchio, una
cicatrice).
Altro foruncolo antipatico, che assilava maschi e femmine,
era invece
lu vriscele piane, che usciva un po'
ovunque sul corpo. Era così chiamato perchè non aveva
alcun foro da quale potesse uscire la
mmárcie (il
pus). In questi casi il medico aspettava che il foruncolo
maturasse e poi, quando si formava la via d’uscita,
le
spriscéve (lo premeva) dal basso verso l’alto, un
po’ al giorno, sino a quando non ne fuoriusciva
lu
vérme (il nucleo).
Anche nel campo ematologico i rimedi, erano spesso
empirici ed artificiosi. Quando qualcuno aveva coaguli
sanguigni o emorragie, oppure la pressione arteriosa era
molto elevata, non esistendo farmaci specifici, per
evitare
ca j calasse nu tocche (che gli venisse un
infarto o una paralisi), un rimedio efficace era
la
sanguàtte (la sanguisuga) con la quale gli facevano
un salasso. La tecnica era quella di applicare in
prossimità della zona malata una sanguisuga, che
succhiando il sangue, avrebbe abbassato la pressione
sanguigna.
La sanguàtte.
Per fortuna, sul finire degli anni '50, quando arrivò a
San Salvo
Franco lu ’nfumìre, i tempi stavano già
mutando. Molte malattie, sopratutto quelle endemiche,
iniziavano ad appartenere al passato, anche se ogni tanto
si manifestavano nuovamente. Era già in atto da qualche
anno la vaccinazione antivaiolosa, che era di competenza
del medico condotto, che praticava con un pennino due
graffi sul braccino del bambino, lasciandogli perennemente
due antiestetiche cicatrici,
la ‘nzártatìure (innesto),
ed erano iniziate anche le prime vaccinazioni di massa,
come l’antidifterica, l’ antitetanica, a cui seguì nei
primi anni ’60 anche quella dell’antipolio, per debellare
la poliomelite, più nota come paralisi infantile.
Anche nel campo farmaceutico le cose erano migliorate.
Seppure l'industria farmaceutica fosse ancora agli albori
della produzione in larga scala, si trovavano in farmacia
i sulfamidici, la penicellina, qualche crema per la pelle,
come l’Antipiol, le prime
pallàtte (compresse) di
Aspro, un antidolorifico, il siero antitetanico. Di
antibiotici, però, almeno quelli intesi come oggi, manco a
parlarne.
Antibiotici o non antibiotici, sulfamidici o non
sulfamidici, la gente in ogni caso era restia ad andare
dal dottore ed anche a prendere medicine, se non quando
j meneve na' bella freme (aveva la febbre alta) ed
era proprio necessario consultare un medico.
Si era sviluppata negli anni una medicina parallela,
contadina, senza bisogno di consultare un medico.
Ad esempio se a qualcuno gli veniva
lu turnadàte
(il patereccio - processo infiammatorio delle dita delle
mani), la cura era fargli mettere il dito dentro
a 'na
pammadore (un pomodoro); se si trattava
de nu
vrugnaróle (di un orzaiolo), non ci si metteva
niente, tanto
gna t’ è meniute accusce’ ze na da je’ (così
come ti è venuto così se ne dovrà andare); stessa cosa per
l'erpes: "
Ne è niende.
Quasse è 'na febbre
annascoste" (Non è nulla. E una febbre nascosta). Se
a qualcuno
jav'è pezzechete 'na lape (era stato
punto da un ape), gli mettevano una lama fredda di un
coltello sulla puntura, per evitare che si gonfiasse, e
nei casi di
’ntunuatìure (piccoli traumi da caduta
con contusioni) gli si faceva
la ’nghiárate, una
specie di ingessatura realizzata con l'albume dell’uovo
sbattuto e
nghe la bommácie (con ovatta).
La
'nghiarate era molto efficace e leniva dopo un po'
il dolore. La si teneva sulla parte dolorante per una
decina di giorni. Poi per verificare se la guarigione
fosse avvenuta o meno, si faceva una prova. Se la
fasciatura, togliendola, faceva male, significava che
la
’ntunuatìure non era ancora guarita, e quindi la si
lasciava ancora lì per qualche giorno, se invece non si
avvertiva più alcun dolore, la guarigione era completa.
Altro esempio. Quando accidentalmente i contadini in
campagna, mentre lavoravano, si procuravano delle piccole
ferite, lo disinfettavano con il di vino, e se il vino non
c’era o era finito, se ne andavano dietro
a 'na fratte
(dietro una siepe) e ci urinavano sopra (l’urina
contiene ammoniaca), al cui contatto la ferita
ngennàve
nu qua’ (bruciava un po’), ma era sempre meglio
dell’ acqua del pozzo che
putàve tena’ la rizze (poteva
avere la ruggine). Per tamponare il sangue di piccole
ferite non c'era nessun problema: tagliavano una canna, ne
estraevano “
l’aneme” (una specie di filtrino che si
trova all'interno di ogni giuntura di una canna) e ce
l’appiccicavano sopra, come un cerotto.
Poi vi era la cultura dei decotti: quelli di malva, di
camomilla, e persino
’nghe le capélle de le grandénie
(con i filamenti o barba del mais), che dicevano
facesse bene alle vie urinarie. Ai bambini, per farli
dormire davano
la pápagne che era un infuso
ricavato
da le pallachícche (dalle teste) dei
papaveri selvatici, fatte esiccare al sole, una droga, che
spesso li faceva dormire per due tre giorni di fila.
Qualcuno lo beveva anche come antidolorifico, per lenire i
dolori di coliche in genere. Pericolosissimo invece era
l'infuso
de petresànne (di prezzemolo) che qualche
maháre (mago-stregone) preparava per procurare
l’aborto alle donne incinte, procurando spesso e
malvolentieri la morte della malcapitata.
Ed a proposito di
maháre, era molto diffusa anche
una medicina alternativa, quella superstiziosa, praticata
da le fattucchijre (dai fattucchieri), i veri
antagonisti della medicina ufficiale. La gente faceva la
fila nelle loro case (venivano persino da fuori),
ritenendoli capaci di far scomparire malattie che i medici
non erano stati in grado di guarire. I fattucchieri
’ncantavene
le malucchie (toglievano il malocchio), guarivano i
bimbi
da la vermenare (dai vermi intestinali) ,
toglievano le fatture di magia nera ed altre diavolerie.
Pronunciavano sottovoce tre o quattre
prihire
(preghiere), facevano dei segni di croce
’nghe nu
curtélle (con un coltello) sopra qualche oggetto e
via… il male spariva d’incanto. Sovente somministravano
degli intrugli realizzati con formule segrete, spesso a
base
de bicarbunate (bicarbonato), che faceva
fare qualche
ribbìffue (rutto) al cliente (anche
se sarebbe meglio dire credente), il quale avvertiva un
senso di sollievo. Molte formule magiche, come quella per
togliere il malocchio, erano a conoscenza anche delle
donne anziane, che se le tramandavano da mamme a figlie,
rinnovandole la notte di Natale.
Erano tuttavia sempre le scarse condizioni igieniche a
creare problemi alla gente. Con le stalle che ancora erano
numerose in paese,
le mascule e le tafane (le
mosche ed i tafani),
te ze magnave véve véve (ti si
mangiavano vivo vivo). Alla gente spesso gli uscivano
li
scarselle, piccole tumefazioni sull’epidermide che
provocavono grattamento dovuto al prurito.
Poi c'erano
li piducchie,
li pigge,
le
cemmicie,
li zàcche (i pidocchi, le pulci, le
cimici, le zecche).
Per loro sfortuna arrivò
lu flit (insetticita,
DDT), che era stata portata dagli inglesi durante la
guerra. Fu
'na cosa sante (una soluzione
miracolosa) anche negli anni successivi. Si spruzzava
nghe la machinàtte de lu flit , una pompa che si
vendeva annessa al prodotto e bastavano poche spruzzate ed
il gioco era fatto:
le maschule (le mosche)
cadevano a terra
sticchite (morte). Qualcuna che
restava a terra
ammupulete (stordita), veniva
acciaccate
nghe lu péte (veniva calpestata con il piede), e
faceva cric sotto la suola delle scarpe. A questo punto le
mamme fecero
'na penzate (un ragionamento): se
funziona con le mosche, perché non dovrebbe funzionare
’nghi li piducchie? (con i pidocchi?) Ed iniziarono
a spruzzarlo sui capelli dei bambini, sostituendo con
successo i lavaggi dei capelli con il petrolio, in voga
anni prima.
La machenàtte de lu flit
E restando in tema di bambini, ieri come oggi, erano le
malattie esantematiche (il morbillo, la varicella, la
rosolia, la scarlattina e la parotite), quelle a cui
le
mammuccie (i bambini) erano maggiormente soggetti.
Le famiglie, in molti casi, dicevano
l'ha da fa'
(lo deve fare), nel senso che era necessario che le
contraessero,
accusce' ze leve lu 'mbeccie na vo' (così
si tolgono l'impiccio una volta per sempre), diventando
immuni. Per questo motivo molte mamme portavano i propri
figli vicino al letto del bambino malato
pe' farejele
arcóje (affinchè venissero contagiati dalla
malattia), sopratutto nel caso della rosolia per le
bambine, che dicevano, a ragione, che era pericolossisima
se contratta in eta adulta durante la gravidanza in quanto
putàve nascie feje defettiuse (potevano nascere
figli anormali) e stesso ragionamento per i maschietti, pe
l
e recchìune (orecchioni, parotite), che da adulti
poteva degenare in orchite, con il rischio di sterilità
riproduttiva.
Questo modo di pensare era diffusissimo e per queste tipo
di malattie c'era anche chi non chiamava neppure il
medico, a cui diventava invece necessario ricorrere quando
un bambino
ze rumpuave la coccie (si feriva al
cuoio capelluto). Infatti, con le strade in gran parte
ancora bianche e con i sassi che ci stavano in giro, ogni
tanto a qualche bimbo, che
faciave la uérre, (che
giocava a far la guerra), gli rompevano la testa e tutte
'nzánganate
(tutto sanguinante), veniva portato all'ambulatorio di Don
Peppino de Vito, che dopo averlo medicato ed avergli
apposto qualche punto di sutura sulla ferita, lo rimandava
a casa, con una benda in testa, come un vero ferito di
guerra.
In quei tempi, nel nostro paese, era così per i bambini.
Non ve n'era uno che non era
smerchelijéte (pieno
di sbucciature),
nghi le varlése a le vìute e li
cocchele de li jnucchie (con numerose escoriazioni
ai gomiti ed alle rotule), dovute alle frequenti cadute
che si procuravano
faciénne la zille mezze a la ve’ (giocando
per per le strade). Per non parlare della condizione
igienica in cui molti versavano. "
A 'sse ràcchie ci ze
po' piantà le pitresénne (in quelle orecchie ci si
può piantare il prezzemolo), si diceva a quei bambini che
avevano il cerume che quasi fuoriusciva dalle orecchie ed
era inutile la visita d'ispezione, a cui il maestro
sottoponeva settimanalmente gli alunni a scuola: i canali
uditivi erano sempre gialli.
E non poteva essere diversamente, visto e considerato che
mentre i genitori erano in campagna,
z’artravvuddavene
‘nterre gne’ perchétte (si rotolavano per terra
come maialini), giocando a far la lotta, sovente scalzi
d'estate e con gli abiti sdrudici, con le ginocchia nere
di sporco, specie quando giocavano
a strísciele o
a palliccie (con delle rotelline ricavate da pezzi
di piatti rotti e biglia di vetro).
Purtroppo l'igiene ai quei tempi era ancora quel che era.
I saponi scarseggiavano e figuriamoci i detersivi. La
gente lavava ancora i panni
nghe la lùsciè (la
lisciva) e le condizioni igieniche, così come le
condizioni di vita delle persone, erano pessime.
C'era chi a quarant'anni sembrava un vecchio ed a
cinquanta spesso dipartiva. Non si usavano tinture per i
capelli; se cadeva un dente, addio, restava sdendato e
sopratutto i duri lavori
scunucchiavene (rendevano
malconci) i contadini, che avevano le mani nere di
campagna ed il collo arso dal sole.
Una sola grossa fortuna aveva la gente di quei tempi e
detta oggi, non era poco.
Non c’erano i tumori, almeno nel numero in cui si contano
oggi.
Erano talmente rari i casi di neoplasie che la parola
cancro, non era ancora in auge persino tra i medici che lo
chiamavano escrescenze, con serie difficoltà diagnostiche.
In questa situazione sanitaria, che ho tentato di
descrivere, simile per molti versi a tanti paesi dei
dintorni, ecco scendere un bel giorno dal treno
Franghe
lu ’nfurmìre.
Aveva lavorato da giovanissimo, come infermiere,
all’Ospedale Civile di Trani ed aveva collaborato anche
con medici dell'esercito durante il servizio militare.
Ora, che aveva messo su famiglia a San Salvo, aveva un
impellente necessità: quella di lavorare.
Ma non era facile.
A quei tempi i medici facevano anche gli infermieri, e per
di più ve n’era già uno, Angelo Sterpetti, il militare
infermiere che era arrivato ai tempi della malaria e non
era più andato via. Angelo collaborava per lo più con Don
Gustavo Cirese,e ogni giorno risaliva in bicicletta
dalla
staziàune (C.da Stazione), dove abitava per
fare iniezioni a mezza San Salvo, spingendosi anche nella
vicina Padìune (C.da Padula in territorio di Montenero di
Bisaccia), pedalando talvolta sino a Termoli.
Viste le premesse, le opportunità di lavoro per un altro
infermiere erano assai scarse, anche perché in ogni
famiglia vi era sempre qualche praticone, o un vicino di
casa, che aveva imparato a fare le punture, e spesso le
faceva a tutti i parenti ed al vicinato.
L'unica soluzione per Franco era quella di entrare nelle
grazie di qualche medico. Assunta si rivolse allora a Don
Peppino De Vito, fresco di laurea in medicina (si era
laureato nel '56), chiedendogli di aiutare il marito a
lavorare come infermiere.
L'idea si rivelò ottima. Don Peppino, che non lo
conosceva, disse ad Assunta di far presentare il marito
l'indomani nel suo ambulatorio di C.so Umberto I.
dr. Giuseppe de Vito
Il giorno appresso, Franco si presentò da Don Peppino e
così nacque tra i due un'ottima collaborazione
professionale, che in un certo senso, fece epoca.
Per farsi apprezzare Franco si alzava di buonora al
mattino e se ne andava da Don Peppino, dove, dopo aver
pulito il pavimento, metteva in ordine l'ambulatorio,
aspettando che arrivasse il medico.
Com'era prevedibile, stando insieme, tra i due si instaurò
una sincera amicizia. Don Peppino prescriveva le terapie e
Franco, girando con una vecchia mototocicletta,
regalatagli proprio da Don Peppino, si recava nelle case
dei pazienti per fare le medicazioni e le punture.
Franco con la sua
motocicletta nel giardino del palazzo de Vito.
Franco si rivelò da subito un ottimo infermiere e anche un
uomo di spirito, e non solo perché usava l'alcool etilico.
Dotato di una vena ironica innata, sempre sorridente, con
una vocina tendente all'acuto, scherzava con tutti in
dialetto tranese, facendo battute a destra ed a manca,
riuscendo a tirar su di morale persino i pazienti che
l'aspettavano a casa. Solo a casa sua era un po' severo,
con i figli, a cui raccomandava sempre di rigar dritto e
comportarsi bene nella vita.
Era un gran chiacchierone, il nostro amico Franco, ma
questo non impedì a Don Peppino di apprezzarne la grande
riservatezza e la sua grande onestà. Mi disse di lui Don
Peppino: "Mai un segreto professionale uscì dalla sua
bocca e mai si appropriò, neppure per errore, di nulla,
nemmeno di una siringa".
Ma purtroppo, come accade al calzolaio che aggiusta le
scarpe vecchie altrui e lui va sempre con le sue rotte,
anche Franco, che curava gli altri, non badava molto alla
sua salute.
Iniziarono a cadergli i denti.
Il suo problema, non era la carie, ma il diabete, quella
subdola malattia che ti mette appetito addosso e ti fa
mangiare a più non posso.
Aveva sempre fame. Per attenuare l'appetito, iniziò a
mangiare qualche caramella, che per un diabetico è veleno.
Poi, per controbilanciare e far calare gli zuccheri nel
sangue, quando si rendeva conto che aveva un po'
esagerato, si comprava due
tre lampascìune
(lampascioni, cipolle amarognole e rossastre, molto
diffuse nella cucina pugliese), che comprava al negozio di
frutta e verdura di
Za' Giuvuannine, a due passi
dall'ambulatorio di Don Peppino, e se le mangiava subito,
sperando di tenere a bada la sua glicemia.
Ne mangiava davvero tante di caramelle, nonostante le
ramanzine di Don Peppino al quale, quasi a volersi far
perdonare, ne offriva ogni tanto qualcuna. Don Peppino,
per toglierle di mezzo le accettava, invitandolo a non
comprarle più. Ma non vi era nulla da fare. Franco gli
rispondeva di star bene e che quel suo diabete non era poi
così grave.
Ma un'altra fame era latente in Franco. Con le sole
punture non è che campasse da gran signore. La famiglia
cresceva e bisognava cercare anche qualche altro lavoro
alternativo, che lo aiutasse a tirare avanti meglio la
baracca.
Cercando di conciliare il suo lavoro da infermiere, se ne
andò a lavorare, sopratutto nei mesi estivi, appresse
(dietro) a la mietitrebbia di Nicola Di Virgilio,
imparando a guidarla. Ma un brutto incidente, che gli
successe in agro di Fresagrandinaria, quando lungo
'na
cóste (una salita di campagna), si appallottò in un
burrone, uscendone miracolosamente illeso, lo costrinse a
tornare sui suoi passi.
Meglio Don Peppino.
Intanto il tempo era passato e San Salvo non era più quel
paesino che Franco aveva trovato, scendendo dal treno, in
quel lontano giorno del 1956. Eravamo negli anni '70 e
l'industrializzazione aveva triplicato il numero degli
abitanti, triplicando anche il carico di lavoro, che per
certi versi rendevano le giornate faticose e stressanti.
Restò in quegli anni sempre fedele a Don Peppino. Lo
tradiva solo la domenica con il dott. Vitaliano Ciocco,
che era il medico sociale della U.S. San Salvo (1967),
mentre egli era infermiere ufficiale al seguito della
squadra.
Era uno spettacolo vederlo all'opera. Non appena un
calciatore cadeva, si alzava di scatto dalla panchina e
con la tuta sociale, scarpe da tennis, un cappellino in
testa e la valigetta del pronto soccorso in mano, correva
a passetti veloci in mezzo al campo, battendo sempre in
volata, tra gli applausi, il dott. Ciocco, che
nghe li
pìte a rungiàtte (con i piedi lievemente orientati
verso l'interno), lo rincorreva come un lento bisonte,
essendo divenuto ormai anziano.
Non prendeva una lira per quella sua missione, il nostro
Franco, solo applausi : faceva tutto per pura passione.
E quegli applausi li meritava tutti, dentro e fuori dal
campo, per essere stato negli anni bui, l'infermiere di
tutti, sopratutto della povera gente, che aveva trovato in
lui un amico fraterno nel momento del bisogno.
Franco Lestingi ,
infermiere U.S. San Salvo, il primo accosciato a
sinistra con la valigietta di pronto soccorso tra le
mani.Il terzo in piedi da sinistra è il dott.
Vitaliano Ciocco, alla sua sinistra il Sindaco
pro-tempore di San Salvo Cav. Vitale Piscicelli, con
accanto a sua volta il Cav. Cilli Virgilio, Primo
Presidente della U.S. San Salvo nel 1967..
Senonché, quando le giornate di Franco sembravano
trascorrere normali, ecco il diabete giocargli un brutto
scherzo.
La voce si sparse in paese in un baleno: Franco era stato
ricoverato d'urgenza all'Ospedale Civile di Vasto. La
diagnosi era tragica: coma diabetico. Lo riportarono a
casa con l'ambulanza. Non c'era più nulla da fare.
Accorse al suo capezzale Don Peppino, informato da
Assunta, ormai disperata.
Lo visitò.
Fatto sta, che non so se per bravura professionale o
perché sperava in un miracolo, Don Peppino intravide un
piccolo barlume di speranza. Senza perdere un attimo di
tempo, tornò nel suo ambulatorio e si attaccò al telefono,
chiamando l'Ospedale: "Venite immediatamente a riprendere
il mio infermiere Franco Lestingi, sono il suo medico e mi
assumo tutta la responsabilità di questa mia azione."
L'ambulanza arrivò e don Peppino la seguì con la sua auto
sino all'Ospedale, pronto ad intervenire per ogni
evenienza durante il viaggio.
Franco salvò ancora una volta la pelle. Il miracolo si era
compiuto, merito dello Spirito Santo e forse dello spirito
di amicizia che lo legava all'amico medico.
Passato il brutto momento, Franco ricominciò a lavorare.
Riprese a fare con quella sua vocina battute a destra e
manca. Sfotteva e veniva sfottuto dagli amici, i quali,
dopo che l'aveva scampata per un pelo, lo soprannominarono
morte e veve (morto e vivo), stesso soprannome di
un antico concittadino che si era svegliato dopo una morte
apparente.
Con il tempo pareva essersi ristabilito, anche se il male
era sempre latente. Ma non durò a lungo. All'improvviso,
le sue condizioni di salute si aggravarono un'altra volta,
anche se sembrava una delle solite crisi a cui la famiglia
era ormai abituata. Franco era cosciente, ma stava davvero
male.
Mentre era a letto, arrivò una telefonata. Era Pasquale
Spinelli, l' ex calciatore ed allenatore del San Salvo, il
quale non sapendo del suo stato di salute, gli aveva
telefonato affinchè Franco si recasse a casa sua perchè
aveva bisogno di farsi fare una iniezione.
Vincenzo, suo figlio, riuscì a trattenerlo a stento nel
letto. Voleva alzarsi e correre da Spinelli, dal suo amico
calciatore, con il quale aveva condiviso gioie e dolori,
trasferte ed emozioni, in quelle domeniche calcistiche in
cui si giocava a pallone.
"Cinque minuti e torno!", disse a Vincenzo.
In fondo la sua vita era stata sempre quella, correre,
correre, correre, quando qualcuno lo chiamava per fargli
fare un'iniezione. Ora si trattava di un amico ed era suo
dovere correre da lui, per fargli, in fondo, solo
un'iniezione.
Qualche giorno dopo se ne andò, per sempre.
Era il 20 gennaio del 1980.
Quel giorno Don Peppino non c'era.
Era in giro per il mondo, a bordo di una delle tante navi
da crociera, su cui ogni anno salpava, come direttore
sanitario, in qualità di 2° ufficiale in ordine di grado,
dopo il comandante in prima della nave.
Don Peppino non c'era!
Chissa!
Il dott. Giuseppe de Vito
ritratto a Buenos Aires. Sullo sfondo la poppa del
transatlantico Giulio Cesare.
NOTE
- Altri medici sansalvesi in quel periodo furono
Lelline Russo, (Angelo Russo), figlio di Tumassine
(Ottorino Russo), che si era specializzato
in malattie infettive e lavorava a al Centro
Antitubercolare di Chieti e l'indimenticabile Do'
Marie Artese, amico del popolo, che era
figlio di Do' Ureste Artese, che negli
anni '60, dopo il matrimonio con Donna Lidia,
sorella di Lillino Artese, il futuro deputato al
parlamento italiano, si trasferì a svolgere la
professione di medico a Como. Al suo ritorno negli
anni '70 fu medico di base a San Salvo oltre che
medico alla Magneti Marelli.
- L' Ospedale Civile di Vasto (anni '50-'60) era
ubicato vicino alla Chiesa di San Pietro in
Sant'Antonio di Padova, ed era composto da due
corpi di fabbrica. Quello principale aveva la sede
in un palazzo su Via Anelli, mentre l'altro in una
casa non molto ampia lì vicino, in via
Sant'Antonio, che i sansalvesi chiamavano "lu
spudalatte" (piccolo ospedale).
- Don Camillo Artese, da quel che dicono, era un
bonaccione. Scapolo era un medico molto
apprezzato, che con la carenza di soldi che c'era
in giro, riusciva a curare la gente con erbe
medicamentose, decotti e terapie non costose, che
quasi sempre coglievano nel segno. Mi raccontava
mio padre che se qualcuno aveva dei dolori
reumatici, gli consigliava di mettere un mattone
vicino al fuoco per farlo riscaldare, e dopo
riscaldato, avvolto in un panno, di tenerlo vicino
alla zona dolorante.
- Un male che affliggeva i bambini era la
vermenare, il mal di pancia, che dicevano
fosse causato alla formazione di vermi nella
pancia del bimbo a seguito di forti spaventi e
paure. Per questo motivo, quando un genitore
sgridava formente al figlio, interveniva sempre
qualcuno, specialmente la nonna, che gli diceva: "Zette,
ne' vede ca mo j fi mene' la vermenare a ssu
cetle? (Non sgridarlo più! Non capisci che
gli stai facendo venire la virmenare a questo
bambino).
-
Spesso capitava che qualche bambino, giocando
in strada, cadeva per terra e sbatteva li
cirvelle (la testa). Se era solo 'nu
vozze 'mbrante (un bernoccolo) o nu
vrógnele (una tumefazione) non era nulla di
grave e non finiva nemmeno la cummedie (il
gioco), ma se ze rumpuave le corne (si
spaccava la testa) o sbattave le froscie, (si
rompeva il naso), le cose si complicavano ed
allora veniva trasportato d'urgenza dal medico.
Ricordo che c'era sempre cacche grosse
(qualche adulto), che si trovava di lì a passare
per caso, che sentendolo piangere tutte 'nzanganate
(tutto insanguinato) e smascherejéte
(irriconoscibile), lo prendeva 'ngolle (in
braccio) e lo portava quasi sempre da Don Peppine
de Vito, che gli disinfettava prima la ferita con
la tintura di iodio, poi j mittave le pinte
(gli metteva i punti di sutura), gli spargeva un
po' di penicillina sulla parte ferita, e 'nghe
la bommácie (con l'ovatta) e lu
sparatrap 'ncape (lo sparadrappo in testa),
lo rimandava a casa, come un ferito di guerra.
All'uscita dall'ambulatorio, dove lo aspettavano
al di fuori gli amici, si atteggiava quasi ad
eroe, capace di avere avuto la forza di affrontare
siffatta disavventura. I suoi compagni gli
chiedevano: "Canda pinte t'ha messe?"
(Quanti punti di sutura ti ha messo Don Peppino?).
In base al numero dei punti si stabiliva il grado
del suo stoicismo alla sopportazione del dolore.
- A San Salvo negli anni '50 e primi anni '60 non
c'era neanche un dentista e la dentiera era un
optional semisconosciuto. Per curare i denti si
andava a Vasto dal Dottor Muzi. Il primo dentista
venuto a San Salvo alla fine degli anni '60, fu il
dottor Goffredo Tilli, poi divenuto medico
condotto, e successivamente ufficiale sanitario.