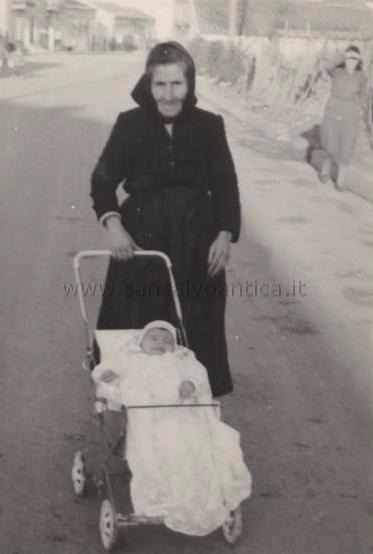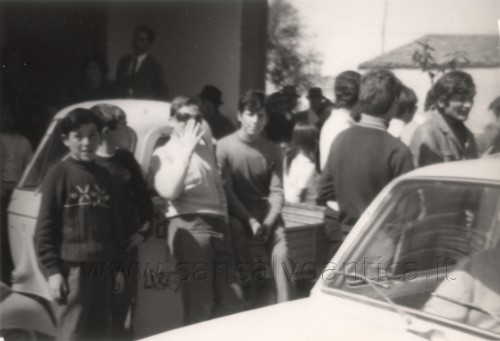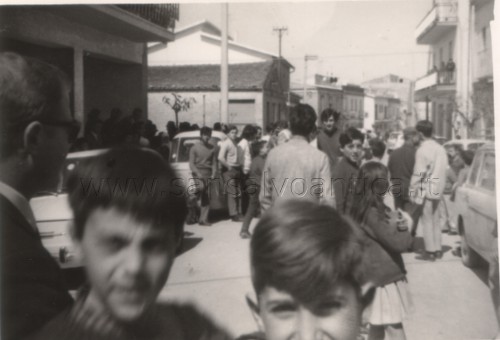Capitolo VI
Vincenzo Larcinese
(Mugnaio)
Giunse invece a San Salvo negli
anni '30, tornando dall'America, un altro famoso
frastire,
che sarà precursore dell'industria moderna molitoria del grano
nel nostro paese.
Il suo nome era Vincenzo Larcinese (1873-1940), nativo di
Fresagrandinaria (
fresciáne).
Vincenzo Larcinese
Vincenzo, che era stato in America ed un po' come tutti gli
americani d'Italia, aveva visto il progresso tecnologico negli
Stati Uniti, tornò a Fresagrandinaria con le idee ben chiare
in mente: aprire un mulino elettrico.
Sino ad allora i mulini erano ubicati tutti in prossimità di
un fiume, in modo da sfruttare l'acqua per far girare le pale
e conseguentemente le macine.
Il nostro amico Vincenzo ebbe l'intuito, avendolo visto in
America, che con l'arrivo della corrente elettrica nei piccoli
paesi d'Abruzzo, il mulino lo si poteva ubicare ovunque, anche
in pieno centro abitato, dove sarebbe stato facilmente
raggiungibile da tutti, perfino da anziani, donne e bambini,
con utenza più vasta e conseguente maggiore introito
economico.
L'occasione propizia gli si presentò nel 1932, allorquando
Michelangelo Ferragonio (
Farrahaune), di origini
pugliesi, dopo aver portato la prima linea di corrente
elettrica a San Salvo, sfruttando anch'egli le pale
dell'antico mulino comunale Pantanella giù alla stazione,
realizzò il primo mulino elettrico sansalvese in Via Roma, a
due passi
da lu Calevarie (dal Calvario), all'epoca
pieno centro abitato e nel contempo quasi periferia del paese,
precisamente nella casa che fu di Pasquale Nicola Cilli (
Nicole
Turluttaune), di professione sarto, marito dell'osterica
Leontina Zamponi, nativa dell'alta Italia.
Via Roma - Il mulino di Vincenzo
Larcinese era ubicato subito dopo l'ultima casa visibile
sulla sinistra.
Nonostante qualche difficoltà iniziale avuta con Ferragonio
sul prezzo inizialmente pattuito, Vincenzo non si fece
sfuggire l'occasione e lo comprò, accingendosi a scrivere
un'altra pagina indelebile della storia
de le mulinére
(dei mugnai) a San Salvo.
Il mulino restò in quella casa per sei anni. Era il 1938,
infatti, quando Vincenzo, dopo aver acquistato
nu lóche
(un terreno edificabile) in Via Traversa Interna (ex Via
Cincovallazione ed attuale Viale Duca degli Abruzzi),
all'epoca estrema periferia del paese, trafficata per andare a
Vasto dai cittadini dei paesi dell'entroterra, vi edificò il
suo mulino.
Purtroppo la sorte non fu benevola con lui: due anni dopo, nel
1940, Vincenzo passò a miglior vita, lasciando la moglie
Giuliàtte
la fresciáne (Giulia Monaco da Fresagrandinaria) ed i
suoi due piccoli figli, Carlo e Luigi, di 12 e 9 anni,
concepiti durante i suoi rimpatri in Italia dall'America.

Toccò a mamma Giulia
rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.
Giuliàtte la mulináre (Giulietta la mugnaia), così
iniziarono a chiamarla i sansalvesi, si rivelò da subito una
donna energica e mamma esemplare, un vero esempio di antica e
rara imprenditorialità femminile.
A darle una grossa mano nella conduzione del mulino ci pensò
Gióse
(Giuseppe D'Addario), persona ricordata con molto affetto
tuttoggi dalla famiglia Larcinese e da molti anziani
sansalvesi, per la sua generosità e laboriosità, emigrato
successivamente in Canada, insieme alla moglie Giuseppina Di
Ludovico.
Anche il mulino Larcinese, da cui in lontananza si scorgeva il
cimitero, ha molte storie da raccontarci in merito al pranzo
delle "Sagne al Mulino", che si svolgeva il giorno delle "Some
di San Vitale", all'incirca una decina di giorni prima della
festa del Santo Patrono.
La storia delle "sagne" al mulino Larcinese inizia dopo la
seconda guerra mondiale. Prima di allora, ad averne
l'esclusiva, era stato Giovanni Bassi, mugnaio del mulino
comunale Pantanella, giù in C.da Stazione. Successe che
con il mulino comunale Pantanella, distrutto durante la guerra
dai bombardamenti, e dopo qualche anno in cui le sagne si
mangiarono ad un mulinetto sul greto del fiume Treste, di
proprietà del Comune di Lentella, sempre gestito da Giovanni
Bassi, le "some di San Vitale", approdarono per la prima volta
a San Salvo paese.
Ve n'erano due di mulini, entrambi elettrici, in quel periodo
a San Salvo: vi era quello antico della famiglia Larcinese,
impiantato nel '32, che sino ad allora non aveva mai ospitato
la manifestazione a causa di una tacita esclusiva che aveva
sempre avuto Giovanni Bassi, essendo il gestore di un mulino
comunale, ed un altro in Via della Mirandola, nuovo di zecca,
costruito dallo stesso Giovanni Bassi, dopo che non era
riuscito a riottenere dal Comune una nuova concessione giù a
Pantanella, nel nuovo stabile ricostruito sulle rovine
dell'antico mulino, destinato ad altri usi, tra cui la scuola
elementare.
I deputati della festa, a questo punto, non esistendo più un
vincolante mulino comunale, si sentirono liberi di scegliere
dove andare a macinare il grano di San Vitale, iniziando a
recarsi una volta ad uno ed un'altra all'altro, a seconda di
dove ritenevano fosse più conveniente.
E fu in quel periodo che la manifestazione, svolgendosi in
paese, assunse per la prima volta nella sua storia, carattere
di vera festa popolare.
Tutti, o meglio quasi tutti, iniziarono a recarsi al mulino.
Tutti, all'infuori delle donne.
Infatti, sebbene andare a mangiare le sagne non fosse vietato
a nessuno, regnava all'epoca ancora un tacito ed atavico
divieto per le donne a parteciparvi.
A farne le spese erano sopratutto le ragazze.
La mentalità paesana imponeva loro di restare a casa
a fa'
la cazzàtte (a fare la calza e svolgere faccende
domestiche), e vi era il divieto assoluto, per le ragazze, non
solo di andare a mangiare le sagne al mulino, ma di
partecipare a qualsiasi manifestazione popolare in cui vi
fossero i maschi.
Ne andava di mezzo la loro onorabilità.
La gelosia dei padri e dei fratelli era talmente asfissiante
che costringeva le ragazze a vivere in una specie di clausura
domestica, uscendo di casa solo insieme ai genitori o ad
amiche fidate.
Tale mentalità era imperante e per molte di loro, ancora negli
anni '60, dopo la licenza elementare, era precluso persino
andare alla scuola media a Vasto, in quanto vi era il serio
rischio che parlassero con i maschi. Era meglio mandarle
a
la mástre (alla maestra di cucito), dove avrebbero
imparato a
fa' le sarténe (fare le sarte).
Naturalmente non è che non vi fosse nemmeno una rappresentante
del gentil sesso, al mulino. A parte le mogli dei deputati,
delegate alla cottura delle sagne, vi era, tra gli astanti,
qualche
ómmene màscule o
masculaùne (donna che
si comportava come un maschio), che non aveva remore di stare
in mezzo ai giovanotti. Era come
'na màscua bianghe
(una mosca bianca), guardata
sopr'ucchie (con occhio
sospettoso, in malo modo) sopratutto dagli anziani, che la
consideravano una poco di buono.
Altre donne che arrivano, verso mezzogiorno, erano alcune
casalinghe attempate, che insieme a figlie e nipoti, curiose e
senza mischiarsi con la folla, aspettavano nei paraggi del
mulino che
cacciassere le sagne (scolassero la
pasta), che ancora fumanti, riportavano a casa dentro
tijélle (tegami) o
spasàtte (insalatiere in
porcellana), per mangiarle in famiglia.
La festa era quindi unicamente
maschile.
Il pranzo si svolgeva in modo differente tra il popolo e le
autorità. Come ai tempi del mulino Pantanella, fuori mangiava
il popolo, mentre dentro pranzavano i deputati e le autorità
del paese, invitati a presenziare, a cui era riservato un
tavolo speciale.
La vera festa, però, era fuori.
La gente, sparsa qua e là, in gruppi e gruppetti nei pressi
del mulino, si portava da casa piatti,
tijélle e
tijllìcce
(tegami) che riempivano di sagne. Era uno spettacolo
vederli mangiare. C'era chi le mangiava
a la rétte (in
piedi), chi
assettate 'ntérre (chi seduto per terra),
chi sotto un albero: insomma ogni posto, possibilmente
all'ombra, era buono
pe' sgangàrejè' (per mangiare) e
attúbbuánáreze gne' péche (mangiare a crepapelle,
gonfiarsi lo stomaco come piche).
Spesso capitava che qualche amico e sopratutto qualche
forestiero, capitato lì per caso, non avesse le posate. Non
era un problema e scattava la solidarietà. Tra la folla, c'era
sempre qualcuno che prendeva una canna, a portata di mano nei
numerosi canneti intorno al mulino, ne tagliava un pezzettino
ad una estremità e dopo aver praticato su di essa, ad un lato,
un taglio a forma di "V" con un temperino, realizzava
'na
freccenélle (un'antica forchetta contadina),
invitandolo ad
abberreté' (avvolgere) le sagne,
mangiandole insieme, nello stesso piatto.
Foto di Umberto Fabrizio - Anni
'50 - Sagne al mulino Larcinese in Via Traversa Interna.
Da sin. Rocchino Boschetti, che si accinge a mangiare le
sagne, seguono Matteo Lozzi, carabiniere, con la camicia
bianca Nino De Francesco, macellaio detto Nine de
Remmechele, Mario Di Memmo, fotografo vastese, segue
persona non identificata. Con gli occhiali scuri è il
compianto Antonino Fabrizio, padre di Vitale, Marco e
Daniele, e zio, per via della mamma di Umberto Di Biase.
Notare le biciclette, ancora mezzo di locomozione molto
diffuso ed il bambino con la scodella che si era portata
da casa.
Com'era inevitabile non mancavano le mbriachìune (i
soliti beoni del paese).
Si prendevano cirte pechere! (sonore sbornie).
Erano un divertimento osservarli. C'era chi, ormai brillo, predecave
(faceva prediche senza alcun senso), chi camminava 'nturtullìune
'nturtullìune (traballante), e chi alla sera, casche
e ne casche (in precario equilibrio), n'arfeléve la
ve' de la case (non trovava più la via di casa), facendo
apparentemente arneha' (bestemmiare) la moglie al suo
ritorno, che a le péchere (alle sbornie) del marito ciavé
fitte l'osse (era abituata).
Dentro al mulino invece, come già detto, mangiavano le
personalità del paese, che z'attárallejévene atturne a 'na
tavelate (si sedevano intorno ad un bel tavolo
imbandito), e nu nu (tra di loro), tra un
ragionamento importante e brindisi, z'attufuévene gne'
péche (si gonfiavano, e non solo lo stomaco, come
piche).
Erano sempre gli stessi: il Sindaco, lu maresciálle
(il maresciallo dei carabinieri), Don Cirille (il
prete), lu mèdeche condótte (il medico condotto), il
capostazione, lu ddaziaróle (il daziere), ed altre
signìure (gente importante) del paese.
A loro erano riservate sagne condite con il ragù di carne,
mentre al popolo solo sugo di pomodoro, alla faccia
dell'uguaglianza sociale.
Disuguaglianze di trattamento e menù a parte, a cui nessuno
faceva caso, perché la gente era abituata alle disparità
sociali, la giornata delle "Sagne al mulino" era un
appuntamento imperdibile per tutti, grandi e piccini, che si
svolgeva in un clima di grande gioia e di fraternità.
Sin dal mattino si respirava nell'aria un'atmosfera
particolare.
Buum!!!
Iniziava con una bomba che sparava a la spruvvuéste
(all'improvviso, senza aspettarselo), che faceva scappà li
cillette (fuggire gli uccelli) e itticà
(sobbalzare) qualcuno per lo spavento.
Era il segnale che la festa stava per iniziare.
Subito dopo, i cavalli, ornati a festa, con la criniera e la
coda addobbati da nastrini variopinti, al guinzaglio dei padroni
in abiti folcloristici, dal punto di ritrovo, partivano in
corteo per le vie del paese, con in groppa
le sàmue (i
sacchi di grano).
La prima tappa era in Piazza Municipio (oggi piazza San Vitale),
dinanzi alla Chiesa, dove ad attenderli, tra ali di folla, vi
era il prete che benediceva
le sàmue (le salme di
grano). Subito dopo vi era la partenza verso il mulino, sfilando
per le vie principali del paese, come a voler ripercorrere,
allegoricamente, la via Vecchia del Mulino, che un tempo
conduceva i nostri avi al mulino Pantanella.
Sflilata delle some in Piazza
Municipio, ora Piazza San Vitale
Che spettacolo, a ripensarci oggi, quei cavalli. Con il primo
cavallo della sfilata, che portava sulla fronte un quadretto con
l'effige di San Vitale Martire, onore riservato a chi aveva
offerto il maggiore quantitativo di grano o di denaro, il
calpestio degli zoccoli sui selciati, infrangeva la quiete di un
paese ancora immerso in un silenzio bucolico. Ogni tanto,
qualche cavallo un po' nervoso, infastidito da questo insolito
clima di festa,
z'arnabbelejéve (si imbazzarriva),
facendo fare largo tutto intorno. Stesso largo avveniva quando
qualcuno di essi
ammullave 'na mmellárde (faceva i suoi
bisogni fisiologici), tra le risate e le battute della gente.
Verso mezzogiorno, nuovi fuochi d'artificio, che facevano
riscappare
li cillétte e
ittica' qualcuno,
annunciavano alla popolazione che il corteo era arrivato
finalmente al mulino e che tra un po' avrebbero
caccìti
(servite) le sagne al mulino.
La festa, a questo punto, raggiungeva il suo apice: tutti al
mulino.
Via Circonvallazione, ora Viale
Duca degliAbruzzi - Luigi Larcinese con il primo cavallo del
corteo, riconoscibile dal quadro di San Vitale sulla fronte.
Infatti il primo posto nella sfilata spettava al cavallo il
cui padrone aveva offerto la maggiore quantità di grano o
somma di denaro. Sullo sfondo il cimitero.
Ma non finiva lì.
A ventenàure (alla ventunesima ora della giornata
contadina, tre ore prima del tramonto precedente), i cavalli,
con in groppa i sacchi di farina, sui quali spiccava una scritta
rossa S.V.M. (San Vitale Martire), ripartivano dal mulino,
sfilando nuovamente per le vie del paese, come a voler ricordare
il ritorno in paese, a sera, degli antichi progenitori che
tornavano dal mulino Pantanella.
Si era giunti all'epilogo della giornata. L'antipasto era stato
servito, ed un clima di festa imminente si impossessava del
paese.
Il 25 Aprile tutti
a la fire (alla fiera), che si
svolgeva giù
a la Madónne (nei pressi della chiesetta
della Madonna delle Grazie), all'epoca periferia, oppure
abbálle pe la fànte (lungo la discesa di via Fontana), e
poi finalmente il 27 ed il 28 Aprile l'apoteosi finale:
la
veggélie e
la feste de Sante Vetale (la vigilia e
la festa di San Vitale).
E' un vero peccato che dal 1993 le sagne non si mangino più ad
un mulino, luogo in cui ebbe origine la tradizione, ma nelle
piazze del paese.
L'ultima volta fu in piena epoca industriale, quando calò
definitivamente il sipario nell'opificio denominato Industria
Molitoria Larcinese di Vincenzo e Carla, titolari di terza
generazione, nipoti del pioniere Vincenzo e figli di Luigi, che
lo realizzò nel 1986.
Anno 1986 - Don Cirillo Piovesan
inaugura l'Industria Molitoria di Larcinese Vincenzo e
Carla. Gli tiene il secchiello 'Ntunine Cirascille (Antonio
Cirese), alla cui sinistra vi sono il Cav. Leone Balduzzi e
Giuseppe Di Stefano (Peppine la uardie, comandante dei
Vigili Urbani). Il secondo da destra è Luigi Larcinese ,
secondogenito di Vincenzo, il pioniere che mise il primo
mulino elettrico a San Salvo.
Con la crescita demografica del paese, era ormai impresa ardua
ospitare tutti i partecipanti.
Da quel giorno la tradizione voltò l'ultima pagina, somigliando
sempre più ad una sagra paesana, con le sagne che iniziarono a
mangiarsi in piazze del paese.
Il tempo passa ed il progresso stravolge ogni cosa.
Il paese oggi si chiama città ed il mulino industria molitoria.
I nitriti, gli scalpitii degli zoccoli e
le mmellárde
dei cavalli sui selciati sono stati sostituiti da trattori
rombanti, che strombazzano con i clacson ed inquinano l'aria.
Tutto è mutato. Anche il nome della manifestazione: non si
chiama più le "Le sagne al mulino", ma "Le sagne di San Vitale".
Una sola abitudine sembra essere rimasta uguale a ieri.
A sgabbejé' (a bere il vino).
C'è sempre qualcuno che, oggi come ieri, si prende
'na bella
péchere (una bella sbronza).
L'unica grande differenza è che fa la pecora nera, scambiando le
sagne con il profano.
La signora Giulia Monaco dinanzi
al mulino di Via Traversa Interna, con il nipotino Vincenzo
Larcinese nel passeggino. .
Anni '50 - Nella foto un'antica pepezzere
che era un dono del mugnaio a San Vitale. Sulla sinistra, in
primo piano, è ritratta la signora Lina Taraborrelli, moglie
di Luigi. Sullo sfondo l'immancabile banda musicale che
accompagnava la pipizzera sino alla casa del vincitore dopo
l'estrazione nella giornata dell'ottava di S.Vitale. .
Anni '60 - Sagne al mulino
Larcinese in Via della Circonvallazione (ex Via Traversa
Interna) ora Viale Duca degli Abruzzi. In primo piano
appoggiati a la lape (all' Ape Piaggio), Rino di Cola con
gli occhiali ed alla sua destra Nicola Iannace. Alla destra
è riconoscibile Umberto Di Biase.
Anni '60 - Sagne al mulino
Larcinese in Via della Circonvallazione (ex Via Traversa
Interna) ora Viale Duca degli Abruzzi. In primo piano i
giovanissimi Lino Checchia a sin. e Franco Di Nardo.
P.S. A proposito di sansalvesi che prima della guerra
emigravano negli Stati Uniti, in cui conobbero per la prima
volta la tecnologia avanzata dell'epoca, si racconta che ad
uno di questi, dopo essere tornato a San Salvo, chiesero quale
lavoro svolgesse in America. E questi, che aveva lavorato in
una fabbrica, rispose in italiano: "A l'Americhe premi un
boton e parte il moton" (In America premi un bottone e
parte un motore).
pag.6

dietro/avanti



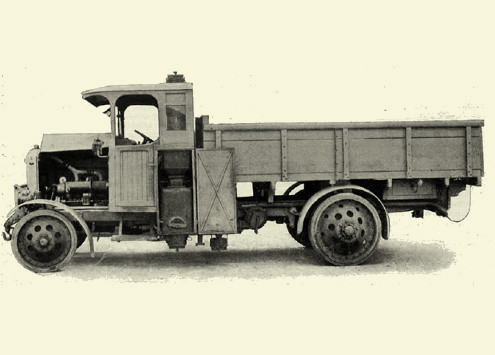




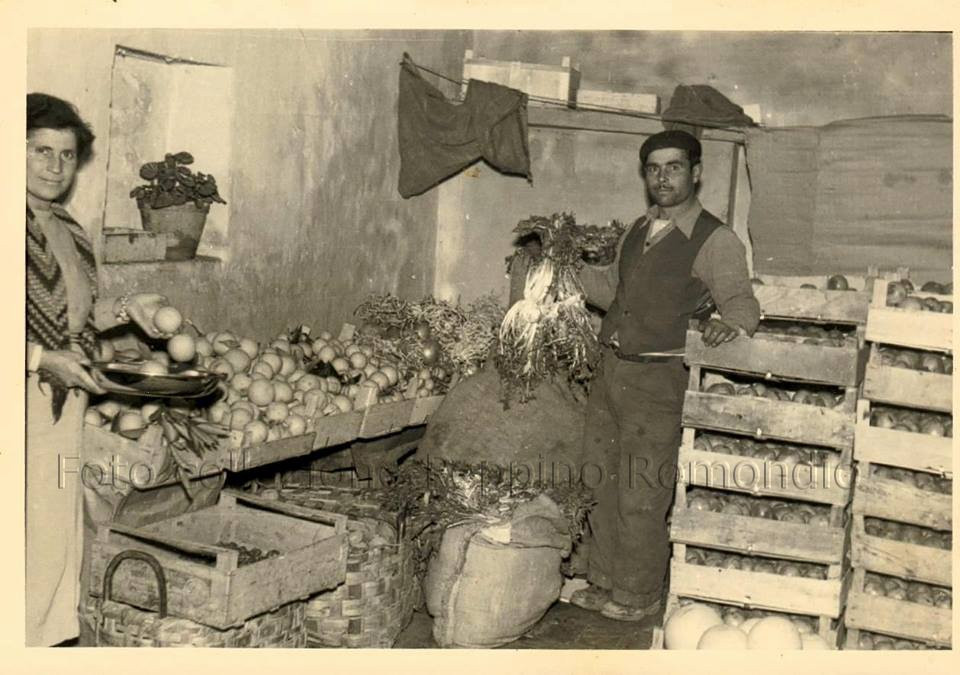





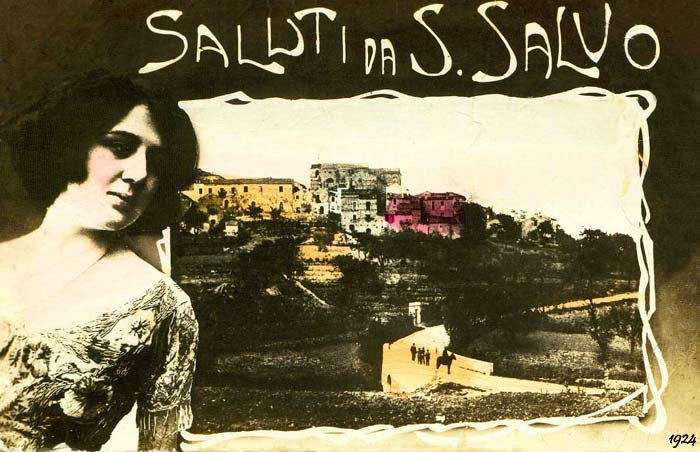






























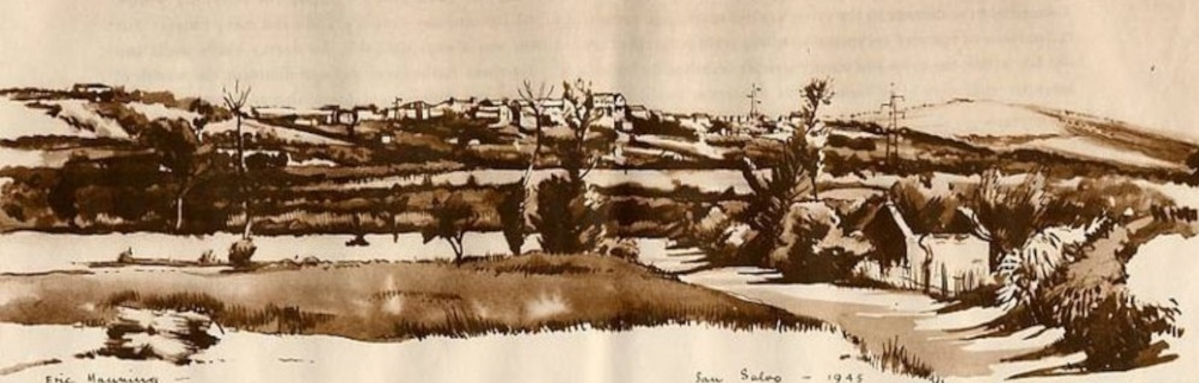



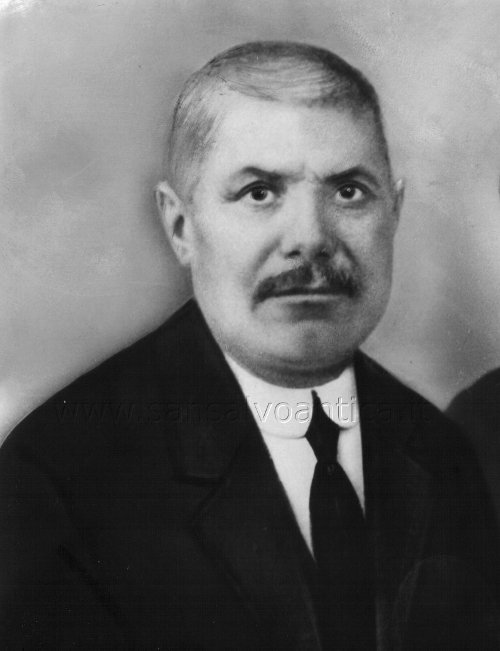

 Toccò a mamma Giulia
rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.
Toccò a mamma Giulia
rimboccarsi le maniche e mandare avanti il mulino.