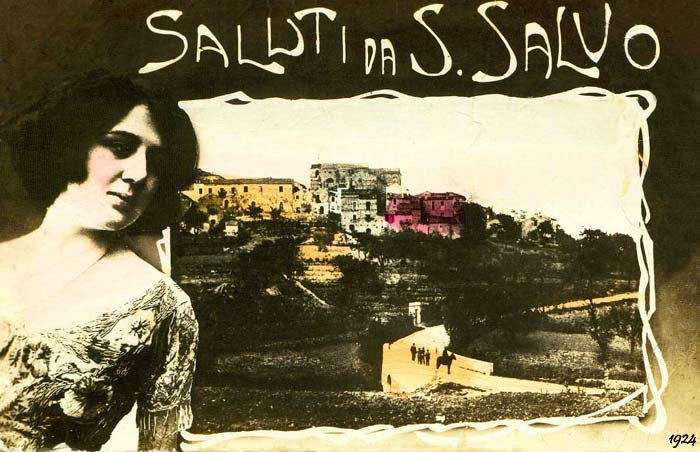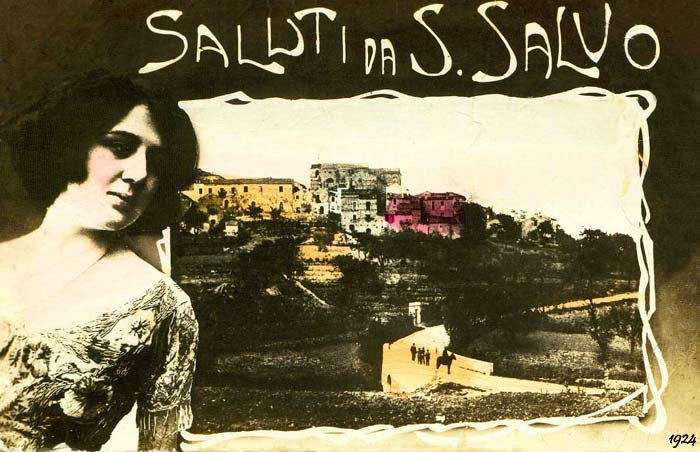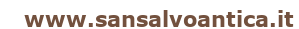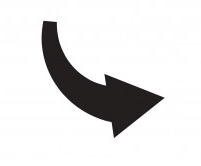Capitolo XXIX
QUANDO LA GENTE
PARLAVA CON GLI ANIMALI
Dipinto di Ergilio Monaco
Ed a proposito di cani veri,
a quei tempi non è che se la passassero poi tanto bene.
Era dura per loro la vita. Facevano, come si suol dire,
davvero una vita da cani, nel vero senso delle parole.
Quasi tutti secche gne’ le chene (magri come
cani), venivano presi a zàvàrre (a pietrate) dai
ragazzi ed erano spesso oggetto anche di scherzi da parte
di buontemponi. Ricordo una mattino sfrecciarne uno di
gran carriera in Via Savoia. Gli avevano legato nu
stágne a la càute (un barattolo di
latta alla coda) e per lo spavento correva come un
forsennato, spaventatissimo dal frastuono del barattolo
inseguitore, che nonostante la sua folle corsa, restava
sempre lì, a portata di coda.
Ma il fatto più singolare è che la gente ci parlava pure
con i cani ed un po' con tutti gli animali domestici, da
cortile e da lavoro. Naturalmente non con lo spirito
francescano del Santo di Assisi, ma riusciva a farsi
capire.
Era una società principalmente contadina quella ed era una
necessità scambiare con loro qualche sillaba e qualche
vocale.
Per far avvicinare un cane, ad esempio, gli si diceva “te’
te’ zu’ zu’ ”; per farlo allontanare “marciallà";
per farlo avventare contro qualcuno “vulè, cià vulè”.
Il cane, quando ciò accadeva, spesso aizzato per scherzo
dal padrone, ringhiava minaccioso verso il malcapitato, il
quale restava fermo sui suoi passi ed un po' impaurito
diceva al proprietario: “Ue’! Archiame quasse!”
(richiama il tuo cane).
Discorsi un po' più complicati invece avvenivano nghe
le chéne de massare' (con i cani di masseria, da
guardia). Appena vedevano qualcuno nei pressi della
masseria abbaiavano e ringhiavano come belve feroci e se
non c'era il padrone nelle vicinanze, era inutile dirgli marciallà.
La prima soluzione che saltava in mente, ma non era
consigliabile, era di prendere 'na zavàrre (una
pietra) e tirargliela, ma se non funzionava erano cavoli
amari: o ci si dava a le cacchiàdre (alla fuga),
ma era meglio non farlo, o ci si arrampicava su un albero,
se fortunatamente ve n'era qualcuno nelle vicinanze. Il
timore era che il cane ze putàve ammena' (si
poteva avventare) e arpezza' le cósse (e mordere
ai polpacci).
Per i gatti invece il linguaggio era un po’ più ridotto,
ma non per questo meno efficace. Per chiamarlo o
accarezzarlo gli si diceva “muscie muscie” (vieni,
vieni che c'è un topo), probabile derivazione dall'inglese
mouse; per farlo fuggire, invece, specie quando combinava
qualche ssadatte (qualcosa che non doveva fare),
gli si gridava con tono di voce adirata “fristquà”.
In quasi ogni casa vi era un gatto. Non lo si teneva come
oggi in salotto, con tante coccole. Il suo compito era
unicamente quello d'acchiappa' (di catturare) i
topi, che nelle case abbondavano. Non tutti i gatti però
avevano questa capacità, molto dipendeva anche dalla fame.
" 'Ssa hatte è surgiagne" (è un gatto bravo a
prendere i topi), si diceva quando uno di essi svolgeva
egregiamente il suo dovere. "Quesse è surgiàgne",
divenne anche un modo di dire tra persone, per indicare
qualcuno che non era fesso e riusciva bene nel suo scopo.
Come già detto, per indurre le bistie (asini, cavalli, e
muli) a camminare, la vocale d’ordine era “ahhhh”;
per farli fermare “ihhhh”. “Tocche tocche”
per farli procedere dritti, senza tentennamenti. Era altra
musica, invece, nel senso che si fischiava, quando si
conduceva uno di essi alla vecchia fontana per farli
abbeverare. All’animale, per invogliarlo ad abbeverarsi,
gli si fischiava fuì fuì fuì, due tre volte
consecutivamente ed a volte anche durante l’abbeveramento,
per non farlo smettere. Da qui nasce il detto popolare
dialettale che dice: “Canda l’asene vo’ bbàve, ‘nci fa
bbesugne ca j cìffule (quando l’asino ha sete non
c’è bisogno di fischiargli), a significare che quando una
persona ha intenzione di fare qualcosa non c’è bisogno di
sprone. Era un’offesa, invece, simulare lo stesso fischio
mentre una persona si dissetava bevendo da una bottiglia o
da nu trìffule (otre in terracotta): "Ue’!
E’che so’ n’asene je!’”, rispondeva quasi sempre con
aria adirata chi aveva scarso senso dell’humor.
Linguaggio più semplice, ma non per questo meno efficace,
era quello con le galline. Per destare la loro attenzione
le dicevano “pìpì pipì” , che ripetuto più volte “pìpìpìpìpìpì”,
significava richiamare in adunata l’intero pollaio. Quando
si dava loro da mangiare si diceva véccie véccie,
mentre per farle rientrare nel pollaio l'ordine perentorio
era scio’ scio’ che le donne, impartivano nghe
‘na granare (con una scopa) in mano, oppure agitando
'na mandìre (grembiule, pettorale da cucina), così
chiamata perchè ammánde (copre).
Anche con i maiali vi erano intrecci di sillabe
incomprensibili, ma appropriati. Per farli spostare o
andare via si diceva loro terrcua' terrcua' (forse
tirati di qua) e per invitarli a mangiare a lu trócche
(al trogolo) chrì chrì. Più o meno stesso
liguaggio con le capre: zrì zrì e l'animale si
avvicinava.
Poi, naturalmente vi erano anche animali domestici a cui
era d'obbligo dare un nome. Erano i cani ed i buoi. Tra i
cani il nome più diffuso era sin da allora Fido, anche se
ognuno poteva sbizzarrisi come voleva, mentre per i buoi,
vacche, vitelli, erano principalmente due: Caggiáne
(gabbiano) e Caggiánélle (gabbianella), forse
perchè, come nei gabbiani, anche in questi bovini prevale
il colore bianco.
"Afféle a lu saleche Caggiá'!" (affila nel solco
Gabbiano), gridavano i contadini, almeno chi si poteva
permettere di possedere un bue, ammonendolo a non uscire
fuori dal solco mentre tirava la pertecáre
(l'aratro). Se non affilava al solco sajuccánne
(bastonate). Anche questo modo di dire ai bovini divenne
per analogia un ammonimento alle persone: lo si rivolgeva
in tono da paternale, sopratutto ai giovani, maschi o
femmine che fossero, invitandoli a rigare dritti e non
sbagliare nella vita.
Ma era tutto il linguaggio, anche tra persone, ad essere
influenzato dalla convivenza quotidiana con il mondo
animale.
Ad esempio per dire che qualcuno si vantava, non si diceva
colui si vanta, ma “ze hallejàje”, a significare
che si atteggiava come un gallo, il re del pollaio.
Riferendosi invece a persone scalognate, che non potevano
farci nulla contro la malasorte, si diceva "povere che
la péchere che n’arpo’ la lane” (povera quella
pecora che non può evitare di essere tosata).
Poi vi erano frasi tipiche che risentivano dell'influenza
del mondo culinario circostante, come ad esempio “quesse
te’ la cicirchie ’ncape” (costuì in testa ha la
cicerchia), per definire una persona assennata, con molta
materia grigia nel cranio, o il contrario "quesse 'nte’
la cicirchie ’ncape", nel senso che è uno
scapestrato o pazzo. “Z’è finìute lu véne a la vàtte”
(è finito il vino nella botte), significava invece che era
sopraggiunta la vecchiaia e la imminente fine della vita
terrena.
Insomma, nonostante fossimo alla fine degli anni '50,
tutto il linguaggio risentiva ancora della cultura
contadina popolare, rimasta per certi versi immobile, da
secoli, tramandata da padre in figlio.
E tornando ai nomi dei cani ne aveva uno da caccia
'Ntonie de Rucchiccie (Antonio Mastrocola). Si
chiamava Fido, nome di cane popolare.
Si racconta che 'Ntonie, rinomato per essere un
abile cacciatore, un pomeriggio se andò a caccia con il
suo Fido cane, che dopo aver puntato un fagiano glie lo
alzò. 'Ntonie lo colpì al volo con una fucilata,
ma cirche e truve, cirche e truve (nonostante le
innumerevoli ricerche ), non vi fu verso di ritrovarlo.
Al tramonto se ne tornò a casa sconsolato ed alla sera ,
dopo cena, se ne uscì per San Salvo, raccontando in giro
ai suoi amici cacciatori la sua disavventura venatoria.
"Scià!!!"(Si!!!), cominciarono a sfotterlo gli
amici. "Secondo me tu ne j si códde!" (Secondo me
tu non lo hai colpito).
"Come ne j'aje codde!" (come non l'ho colpito). "J'aje
códde eccome" (L'ho colpito eccome), cercava di
convincerli 'Ntonie.
"Tu ne j si' códde", rincarava il dubbio un altro
amico cacciatore.
"Je j'aje codde!", gli rispondeva 'Ntonie, sempre
più indispettito.
Fatto sta che tra nu' j'aje códde e tu ne j si códde,
si fece tardi ed andarono a dormire.
'Ntonie non ci dormì la notte. La mattina seguente
si alzò di buonora ed insieme a Fido, tornò sul luogo del
fagianicidio e ritrovò il fagiano.
“Ah Fi’! Doppe dece ca je’ ne ’ncóje” (Eh Fido! Poi
dicono che io non colpisco), ripeteva ogni tanto 'Ntonie
al suo cane, mentre tornava a piedi in paese, non vedendo
l’ora di dire ai suoi amici che si erano sbagliati.
A ripensarci oggi, era per certi versi divertente quella
società contadina, nonostante le difficoltà quotidiane, ed
aveva un suo fascino particolare.
Sebbene la gente avesse un sacco di problemi, le giornate
trascorrevano liete e serene, senza troppe pretese, almeno
ai miei occhi da bambino. La gente si era abituata a quel
modo di vivere, non aveva grilli per la testa, sapeva
accontentarsi di poco e sopratutto vi era molta modestia e
la consapevolezza del proprio stato economico e sociale,
migliorabile solo con il duro ed onesto lavoro.
Si viveva tutti insieme, uomini, asini, e galline, ognuno
occupando i propri spazi e ruoli.
Le galline, ad esempio, lasciate libere, beccavano vermi
ed altre cibarie per strada, immancabilmente disturbate da
qualche bambino che le rincorreva. Era difficile per un
bambino catturare una gallina. Il volatile, per modo di
dire, appena intuiva che qualche monello stesse lì lì per
catturarlo, provava a sollevarsi con le ali per pochi
istanti ad un palmo dal suolo e squacarijénne
squacarijénne (chiocciando chiocciando), dopo breve
volo, riatterava con le zampe che muoveva in rapida
successione, dando inizio ad una folle corsa a zig zag,
girando il collo a destra ed a manca, per capire con la
coda dell’occhio dove fosse in quel momento l’inseguitore.
Il gioco, quasi sempre, non durava a lungo. La padrona, da
dentro casa, sentendola crocchiare, si affacciava
sull’uscio ’nghe ’na mázze de gránare (con una
scoppa in mano) e sbraitando contro il monello, lanciava
verso di lui la scopa che, se la mira era buona, e spesso
lo era, si infilava tra le gambe del bambino, facendogli
fare 'na belle capelótte (un bel ruzzolone).
Le galline producevano le uova ed erano un bene prezioso
per le famiglie. Andavano preservate.
"Magne lu coccò! Magne lu coccò feje me'!" (Mangia
l' uovo, mangia l'uovo figlio mio), dicevano le mamme e le
nonne ai bambini quando li vedevano un po' sciupatelli.
Era reato rubare una gallina. Se qualche volta,
malauguratamente qualcuna di esse finiva sotto le ruote di
un automobile in transito, era proibito raccoglierla e
riportasela a casa. Si rischiava la galera.
Ma ogni tanto, purtroppo per le casalinghe,
sfortunatamente ne spariva qualcuna e non sempre per colpa
degli zingari, che all'epoca si accampavano in periferia.
Era un dramma per la padrona, quando, ricontandole a sera,
ad una ad una, mentre rientravano nel pollaio, si
accorgeva che ne mancava qualcuna all'appello. Se ne
andava su tutte le furie.
I ladri di galline erano difussimi nella zona. Spesso
erano baldi giovanotti, che un po' per gioco ed un altro
po' per fame, le sottraevano per strada o di notte nei
pollai per farne lauti pranzetti.
Mi raccontò un giorno il mio amico Antonio Del Gesso, di
Tavenna, che un giorno stessa sorte toccò ad un gallo
tavennese. La padrona lo cercò per ore e ore, ma non
riuscì a trovarlo. Alla fine, resasi conto che era finito
in qualche padella, riferendosi ad ignoti, così sbottò ad
alta voce: “'Sti disgrazijate! Ze l’hanne magnate lu
halle me! Chi j puzza sci' li pénne mbaccie!”
(Questi disgraziati! Si sono mangiati il gallo mio!
Possano spuntare a loro le penne in faccia!). Poi in
maniera apparentemente riflessiva, giusto per far credere
ad un'altra donna del vicinato, che aveva un valido motivo
per lamentarsi della perdita del gallo, aggiunse: "Ni è
tante pe' lu halle! (Non è tanto per la perdita del
gallo!). “T’avesse vulute fa vvedé’ gna ’ccalicave
belle lu halle me!” (Ti avrei voluto far vedere come
montava bene le galline il gallo mio).
Eh si, era una vera tragedia quando rubavano un gallo o
una gallina. Figuriamoci quando spariva tutto il pollaio.
Se non ci pensava qualche faina, donnola o cane pizze
(puzzola), sovente erano le epidemie, come l'aviaria per
le galline o mixomatosi per i conigli, a svuotare i pollai
o gli allevamenti.
Nei primi anni ‘60 vi fu nu cciudáje (una moria)
di galline e qualche tempo dopo anche di conigli. I
conigli contraevano la malate’ de le cunéje
(malattia dei conigli). J za bbuttáve l'ucchie e la
coccie (si gonfiavano ad essi gli occhi e la testa)
e dopo qualche giorno li trovavano morti dentro le gabbie.
Stessa sorte finale per le galline, che ze sciminévene
(diventavano ancor più sceme di quanto già si dica che
siano) e non respirando bene, incominciavano a camminare
'nturtullìune 'nturtullìune (perdendo
l’equilibrio), sino a sténne le pite (cadere a
terra stecchite). Era considerato pericoloso per l’uomo
mangiare la loro carne e quindi i loro corpi venivano
buttati o sepolti per non far sviluppare la malattia.
Si racconta che a San Salvo vi fu una epidemia di aviaria
nel ‘61 e morirono quasi a tutte le famiglie le galline.
Si salvarono solo quelle de Za’ Deléne Cardarelle.
“Eh brave a za Deléne! A segnuré 'nte
z’è murte le hallene!” (E brava a zia Adelina! A te
non sono morte le galline), le disse una vicina di casa,
quasi a volersi a congratulare. Za’ Deléne, che
era vedova, ricordando antichi dolori, con una lieve vena
polemica, le rispose: "E che t'aja déce feja ma'! E
canda z’è mórte lu maréte a Za' Deléne, allàure
z’avevena muré’ le maréte a tutte Sande Salve?" (E
figlia mia, cosa vuoi che ti dica. Allora quando è morto
il marito a zia Adelina, forse dovevano morire tutti i
mariti sansalvesi?).
Mi disse una volta Giovanni Di Iorio, sarto, emigrato nel
’57 giovanissimo a Parigi, ricordando quei tempi e com'era
San Salvo prima che emigrasse in Francia: "San Salvo
contava più o meno circa 3.000 abitanti, compresi i
maiali, gli agnelli e le galline".
Forse avrà un po' esagerato. Ma non aveva tutti i torti.
pag.29